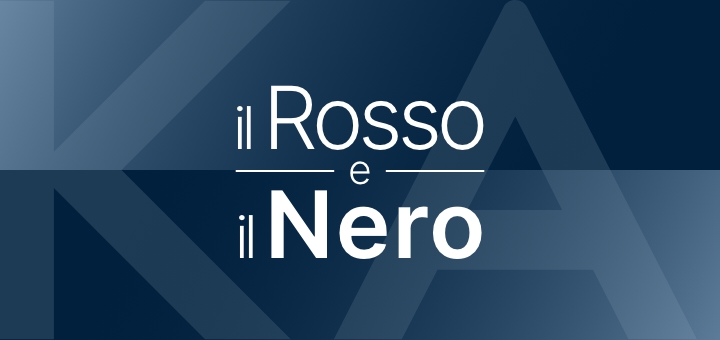
MINIERE
Quando scoppiò la bolla dei titoli legati a Internet, il settore che andò più controtendenza nel periodo successivo fu il minerario. L’indice scendeva, la tecnologia implodeva, l’economia rallentava e i titoli delle materie prime salivano.
Quando scoppiò la bolla dei titoli legati a Internet, il settore che andò più controtendenza nel periodo successivo fu il minerario. L’indice scendeva, la tecnologia implodeva, l’economia rallentava e i titoli delle materie prime salivano.
Una ragione del lungo ciclo rialzista fu ovviamente la Cina. Con un programma di sviluppo a tappe forzate e con 15 milioni di persone che si spostavano ogni anno dalle campagne alle città e a cui bisognava offrire un’abitazione, la domanda cinese di materie prime divenne insaziabile.
La seconda ragione fu un fisiologico processo di rotazione. La bolla aveva indotto a uscire dai settori tradizionali, comprimendone le valutazioni, per finanziare gli acquisti di titoli tecnologici. Al picco, i multipli dei titoli legati a Internet erano stratosferici e quelli dei minerari erano ai loro minimi. Al suo scoppio, si mise in moto un processo contrario.
Quest’anno, il settore che sta andando meglio nell’azionario è l’oil service, l’insieme di quelle società che offrono assistenza nella prospezione e nell’estrazione di petrolio. Ma vanno molto bene i produttori di materie prime in generale e, in particolare, quelli legati a rame e terre rare.
Anche questa volta ci sono due ordini di ragioni per questo comportamento, uno legato ai fondamentali e l’altro alle rotazioni.
I fondamentali sono particolarmente favorevoli ai metalli legati alle nuove tecnologie. Il rame è onnipresente nei data center, nelle reti elettriche da rinnovare, nelle batterie per le auto. È difficile essere positivi sull’intelligenza artificiale senza esserlo anche sul rame. Lo stesso vale per l’argento. Utilizzato nell’elettronica, nei pannelli fotovoltaici, nelle infrastrutture 5G e nel biomedicale. La domanda cresce, ma l’offerta è poco elastica. Si fa prima ad aprire una nuova fabbrica di semiconduttori che a trovare e rendere sfruttabile una nuova miniera.
La rotazione, dal canto suo, ha come ragioni di fondo il desiderio di portare a casa le plusvalenze sulla tecnologia da una parte e il desiderio di rimanere investiti sull’azionario dall’altra. Non siamo infatti in un contesto di fine ciclo, da sempre favorevole a ritardatari come le materie prime. Siamo anzi in un contesto di crescita forte e in possibile accelerazione, almeno per quest’anno.
Il risultato di queste prese di profitto e di queste rotazioni è che oggi i multipli di Exxon o di Chevron sono uguali o più alti di quelli di Microsoft, Google o Meta. Dal canto loro, i multipli di grandi produttori di rame come Freeport o Glencore sono più alti di quelli di Nvidia o di Broadcom. Nel 2000, del resto, il grande rialzo dei minerari partì, come abbiamo visto, da valutazioni compresse, ma non si può dire lo stesso questa volta.
Ridimensionare la tecnologia e diversificare in tutto il resto è una delle raccomandazioni che si sentono più spesso in questo periodo, ma è legittimo chiedersi se questa strategia, che ha avuto negli ultimi tre-quattro mesi molto successo, abbia ancora senso. La nostra conclusione è che abbia certamente senso mantenere un portafoglio azionario diversificato, ma che sia meglio essere cauti nel vendere ancora tecnologia in discesa per comprare ciclici e valore in salita. E’ infatti difficile, a questo punto, vedere grandi squilibri di valutazione, almeno nelle società ad elevata capitalizzazione.
Tra una major del petrolio e uno dei Magnifici Sette i pro e i contro cominciano a pesare uguale. Le grandi del petrolio sono ottimamente gestite e hanno imparato da tempo l’arte dell’autodisciplina nelle spese in conto capitale. Offrono un buon livello di affidabilità e hanno mostrato di sapere navigare attraverso i cicli economici e le fluttuazioni di prezzo del greggio con molta abilità. Dal canto loro, le grandi della tecnologia non stanno mostrando la stessa autodisciplina e danno talvolta l’impressione di investire somme imponenti più per non rimanere indietro nella corsa all’AGI o all’ASI che non per la ragionevole certezza di un buon ritorno sugli investimenti.
Dall’altro lato, tuttavia, le società petrolifere non possono nemmeno sognare i tassi di crescita potenziali della domanda di tecnologia. Solo quelle che producono rame possono competere, ma i loro multipli sembrano già riflettere la forte crescita ipotizzabile. La tecnologia, dal canto suo, vive al suo interno una competizione che, pur in presenza di una forte domanda, ne può erodere significativamente i margini.
La scelta appare dunque difficile. Un argomento importante a favore dei ciclici è che un contesto di forte crescita globale come quello che si profila per il 2026 allarga l’ottimismo a tutti i settori che erano stati trascurati quando a brillare era stata solo la tecnologia. Va però ricordato che gran parte della crescita, per lo meno negli Stati Uniti, sarà dovuta agli investimenti, più che ai consumi, e che gli investimenti saranno in larga misura indirizzati all’Intelligenza Artificiale. Se questi investimenti un giorno rallenteranno, si indeboliranno anche la crescita complessiva e le ragioni per sovrappesare i ciclici tradizionali.
Diversificare, quindi. E diversificare anche all’interno del grande mondo dell’Intelligenza Artificiale, che con le correzioni recenti ha molto ridotto gli squilibri tra chi spenderà soldi e chi li incasserà.
È probabile che la rotazione dalla tecnologia al resto abbia, inerzialmente, altra strada da percorrere nei prossimi mesi. Molto è già però stato fatto e attenzione alle violente e immancabili controrotazioni.
ARCHIVIO
Alessandro Fugnoli
Strategist
In Kairos da gennaio 2010, è Strategist e autore de “Il Rosso e il Nero”, newsletter finanziaria settimanale di strategia d’investimento.
Ha iniziato la sua carriera come Account Executive presso Merrill Lynch Milano; dal 1987 al 1989 ha lavorato per Gestnord Fondi come Direttore Investimenti e dal 1989 al 1994 per Caboto Group nella ricerca macro, strategica e quantitativa.
Nel 2001 ha ricoperto presso Abaxbank il ruolo di Head of Research and Investment Strategist.
Laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano.