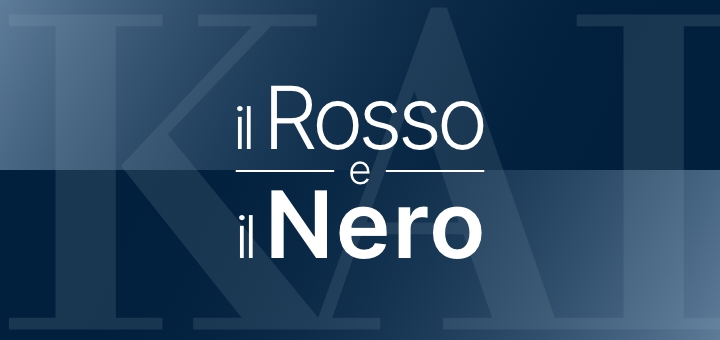
AMERICA E FRANCIA
In ogni città grande o piccola d’America ci sono una strada o un monumento dedicati a La Fayette, a Franklin e a Jefferson. Il primo, aristocratico con doppia cittadinanza francese e americana, combatté prima a fianco degli insorti nella guerra d’indipendenza contro gli inglesi e poi fu protagonista della Rivoluzione francese. Franklin e Jefferson, padri fondatori della nazione americana, furono invece per molti anni ambasciatori a Parigi presso quel re di Francia, Luigi XVI, che aiutò molto i rivoluzionari americani anche se più tardi finì ghigliottinato dai suoi.
In ogni città grande o piccola d’America ci sono una strada o un monumento dedicati a La Fayette, a Franklin e a Jefferson. Il primo, aristocratico con doppia cittadinanza francese e americana, combatté prima a fianco degli insorti nella guerra d’indipendenza contro gli inglesi e poi fu protagonista della Rivoluzione francese. Franklin e Jefferson, padri fondatori della nazione americana, furono invece per molti anni ambasciatori a Parigi presso quel re di Francia, Luigi XVI, che aiutò molto i rivoluzionari americani anche se più tardi finì ghigliottinato dai suoi.
Dalla prima metà del Cinquecento, del resto, la Francia era stata di casa nel Nord America molto più della Gran Bretagna. La Nouvelle France si estendeva dal Quebec al golfo del Messico e occupava tutte le Grandi Pianure, mentre le Tredici Colonie erano una piccola striscia di terra lungo l’Atlantico. E quando Napoleone, bisognoso di soldi, vendette la Louisiana agli Stati Uniti, pensò in fondo a uno scambio tra vecchi amici.
Un’eco di quei tempi eroici è ancora oggi riscontrabile nell’autorappresentazione dei due paesi. L’universalismo e l’eccezionalismo sono infatti tratti che, insieme, sono presenti nel nostro mondo solo in Francia e in America. Entrambe ritengono di avere una missione universale. Entrambe, in quanto portatrici di luce e di progresso, ritengono di essere moralmente superiori, quando è necessario, alle regole che si applicano al resto del mondo (America) o d’Europa (Francia).
Tra le varie declinazioni dell’eccezionalismo, la possibilità di mantenere eterni e ampi disavanzi delle partite correnti e dei conti pubblici senza che nessuno abbia troppo da ridire è tra le più evidenti. Per gli Stati Uniti questo coincide con il ruolo di fornitore della valuta di riserva del mondo, il dollaro. Per la Francia coincide invece con il ruolo di vincitore (con l’aiuto americano che ricambiava quello francese di due secoli prima) della guerra secolare franco-tedesca e con il conseguente primato politico sull’Europa continentale.
C’è però una differenza. L’America non ha mai ceduto la sua sovranità, la Francia ne ha ceduta parecchia, almeno formalmente, all’Europa. L’ha fatto con l’idea che l’Europa fosse semplicemente l’esoscheletro della Francia, ovvero una struttura più grande e più potente della Francia che era però diretta di fatto da Parigi e a Parigi forniva una leva di potenza più lunga.
Certo, nella fase dell’innocenza economicista che va dal 1989 al momento in cui la Cina ha cominciato a fare paura, la Francia è sembrata la sorella minore di una Germania in asse con la Russia. Ma i politicisti anni Venti hanno portato in rapida sequenza alla rottura dell’asse Mosca-Berlino, all’indebolimento dell’apparato industriale tedesco, all’emergere del nucleare francese come unica fonte certa di energia per l’Europa e all’atomica francese come nucleo duro del futuro esercito continentale impegnato, insieme all’America, a tenere testa alla Cina e alla Russia.
È sembrato per un momento il trionfo strategico della Francia. Questo trionfo non è ancora in discussione, ma dopo il voto delle prossime settimane, ci sarà un periodo di tensione di mesi o anni tra la Francia interna e la Francia in esilio a Bruxelles e a Francoforte, rappresentata forse un giorno da un Macron presidente europeo che si confronterà con la ribellione (se sarà ancora in corso) dei suoi cittadini.
Nel frattempo, nelle stesse ore, il Congressional Budget Office alza le stime sul disavanzo pubblico americano di quest’anno (da 1.5 a 1.9 trilioni) e corregge al rialzo quelle per i prossimi dieci anni, mantenendole per tutto il tempo sopra il 6 per cento. Il mercato non reagisce, l’eccezionalismo americano è ancora solido.
Il mercato reagisce invece alle stime sul disavanzo francese dell’anno prossimo, non a quelle esagerate basate sui programmi elettorali, ma a quelle più realistiche, che emergono da una stima di quello che il prossimo governo sarà in grado di fare. Prima di tutto non è per niente scontato che emerga dal voto un vincitore con maggioranza assoluta (c’è quindi la possibilità di un governo tecnico con ritorno al voto fra un anno). Se invece emergerà, avrà subito contro tutti e dovrà scegliere tra la rottura con Bruxelles e con Macron e il dialogo. La rottura complica la possibilità di ottenere l’Eliseo nel 2027, il dialogo diluisce il programma e porta a un disavanzo che sarà, al massimo, di un punto più alto del 5.5 attuale.
Sarà anche meno, probabilmente, ma anche ipotizzando un 6.5 nel 2025, avremmo un disavanzo francese identico a quello americano e un rapporto tra debito (sia lordo sia netto) e Pil anch’esso molto simile. La differenza è che la parte di debito detenuta dalla Fed è politicamente più controllabile di quella detenuta dalla Bce.
Sia come sia, dobbiamo prepararci a disavanzi vicini al 6 per cento tanto in America quanto nel cuore dell’Europa per un periodo molto esteso. Come si comporteranno le banche centrali in questo scenario di lungo periodo?
David Andolfatto, che ha lavorato molti anni alla Fed (monetarista) di St. Louis a fianco di Bullard, sostiene, conti alla mano, una tesi controintuitiva. In un orizzonte lungo di disavanzi coperti da debito e non da tasse, se la banca centrale alza molto i tassi fa scendere l’inflazione nel breve, ma la fa salire nel lungo. Alti tassi e alti disavanzi, insieme, arrivano rapidamente a un circolo vizioso, che accelera quando gli alti tassi portano alla recessione. In pratica, o il governo risana i conti sul serio (con tasse o tagli di spesa) oppure la banca centrale deve tenere i tassi più bassi che può (si veda, come riferimento, Is it time for some unpleasant monetarist arithmetic? su MacroMania del 4 marzo 2021).
Inutile aggiungere che uno scenario di forte e permanente stimolo fiscale e di tassi bassi sarebbe molto favorevole per le borse.
ARCHIVIO
Alessandro Fugnoli
Strategist
In Kairos da gennaio 2010, è Strategist e autore de “Il Rosso e il Nero”, newsletter finanziaria settimanale di strategia d’investimento.
Ha iniziato la sua carriera come Account Executive presso Merrill Lynch Milano; dal 1987 al 1989 ha lavorato per Gestnord Fondi come Direttore Investimenti e dal 1989 al 1994 per Caboto Group nella ricerca macro, strategica e quantitativa.
Nel 2001 ha ricoperto presso Abaxbank il ruolo di Head of Research and Investment Strategist.
Laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano.